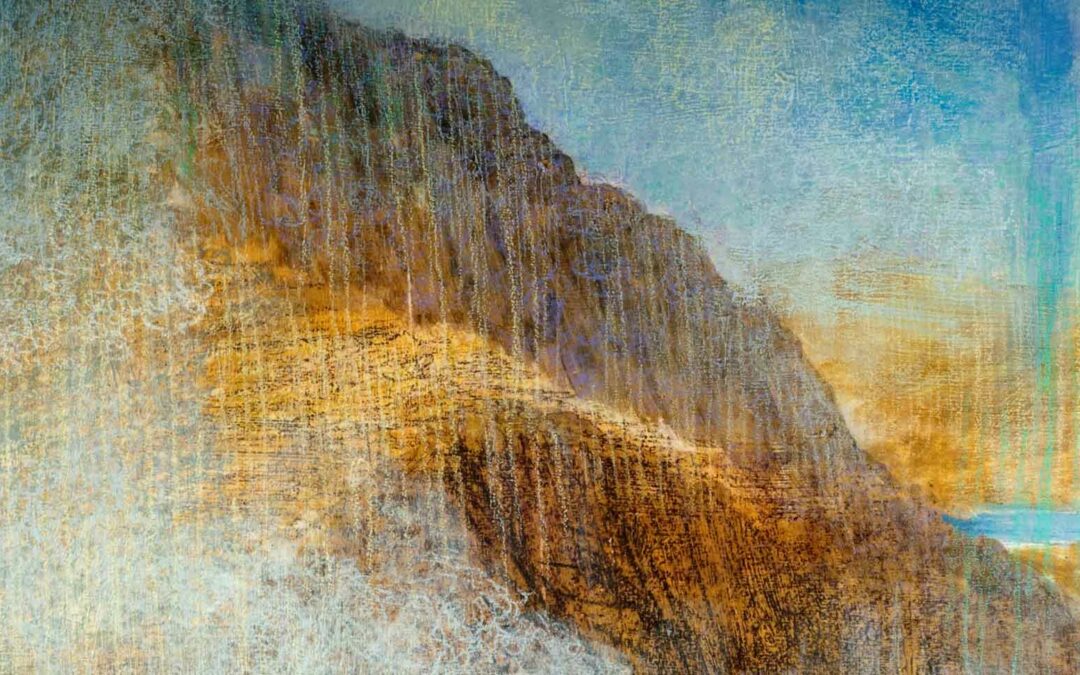Ho 79 anni, vivo a Roma e faccio parte dell’Ufha (Unione Famiglie Persone con Disabilità). Il 2 novembre 2020 è tornato al Padre Alberto, il nostro unico figlio, che quest’anno avrebbe compiuto 51 anni. Cerebroleso e gravemente disabile dalla nascita, quindi “paziente non collaborante”, era stato ricoverato in ospedale per un intervento salvavita e lì, infettato dal covid, è deceduto. Non abbiamo potuto assisterlo e non lo abbiamo più visto né vivo né morto. Non debbo certo dire cosa significa perdere un figlio e, soprattutto, perderlo in tal modo: voglio, però, promuovere un’iniziativa per far sì che la morte di Alberto sia lo stimolo per cercare di migliorare la vita dei “pazienti non collaboranti”.
Nei suoi 49 anni di vita Alberto ha dovuto affrontare, e noi con lui, visite e degenze in strutture sanitarie per periodi più o meno lunghi. Mi sono così resa conto di cosa comporti una visita medica o l’eventuale ricovero di un “paziente non collaborante” il quale, per definizione, non può fornire informazioni, non può rispondere alle domande di rito né segnalare problemi. Non è mia intenzione mettere sotto accusa il personale sanitario: la pandemia ha messo in risalto la dedizione e lo spirito di sacrificio di coloro che hanno cercato di salvare più vite, talvolta perdendo la propria. I familiari delle persone con disabilità sanno, però, quanto sia impegnativo e difficile instaurare un rapporto o anche solo un contatto con chi necessita di tempo e pazienza, risorse poco disponibili per medici, odontoiatri e paramedici. Sanno anche quanto ogni variazione dalla routine provochi scompensi. Ecco perché serve qualcuno che, conoscendo a fondo il soggetto, funga da mediatore.
In ogni caso, dunque, è necessaria la presenza di un familiare o di chi assiste il paziente con disabilità, trattandosi degli unici conoscitori dei molteplici aspetti della sua vita, e di tutto ciò che non può essere direttamente comunicato. Purtroppo ciò non avviene nella maggior parte dei casi anche se in realtà i familiari, oltre che rassicurare il paziente, potrebbero aiutare in molti modi il personale, che non ha alcuna specifica preparazione in tema, con conseguenze spesso gravi. Esistono carenze e difformità di valutazione e trattamento che distinguono, con effetti a volte pesanti, i pazienti non collaboranti dagli altri. Faccio due esempi: la Guardia Medica non è tenuta a intervenire se il paziente non è collaborante (ciascuna sede locale può deliberare in merito come ritiene più opportuno); alcuni accertamenti diagnostici sono possibili solo su pazienti collaboranti (come l’accertamento di disfagia per l’eventuale impianto di Peg, una difformità discriminatoria inaccettabile in quanto le conseguenze dell’impianto sono pesanti).
Quando appresi che l’Ordine dei medici di Roma aveva organizzato il corso di aggiornamento Le Cure Mediche e i percorsi di Presa in Carico delle Persone con Disabilità, quale madre di figlio fragile vi partecipai. Approfondii, parlai con familiari e addetti ai lavori, scoprendo realtà che ignoravo, nonché l’esistenza di norme e disposizioni statali e regionali emanate a seguito della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. Ad esempio il progetto Dama; la legge della Regione Lazio che adotta la Carta dei diritti delle Persone con Disabilità in Ospedale; alcuni provvedimenti regionali secondo cui chi assiste il paziente con disabilità possa seguirlo in ospedale; l’implementazione, in almeno due ospedali per provincia, di un servizio di accoglienza e assistenza medica dedicato, costruito sul modello Dama; l’apertura a Roma di un ambulatorio infermieristico per la gestione sociosanitaria di persone con disabilità cognitivo-comportamentale complessa non collaboranti.
Ciò premesso, si chiede agli enti in indirizzo di promuovere e diffondere su larga scala corsi di formazione per il personale medico e paramedico; di promuovere e diffondere negli ospedali percorsi specifici di accoglienza e presa in carico dei pazienti non collaboranti (cfr. progetto Dama); di disporre che, ai familiari o a chi assiste un paziente non collaborante, sia sempre consentita la presenza in ospedale; di disporre che ausili medici indispensabili siano per tutti del tipo più sicuro; di pubblicizzare al massimo l’esistenza di iniziative e strutture di aiuto alle famiglie; di estendere l’intervento del personale di guardia medica anche per i pazienti non collaboranti; di informare pazienti e familiari su ogni procedura e/o somministrazione disposta dai medici, in particolare se da attuare a domicilio.
Non si chiede che i pazienti non collaboranti abbiano trattamenti migliori o privilegiati, ma che ricevano trattamenti idonei a fornire loro l’accoglienza, l’assistenza e le cure consone alle loro specifiche esigenze.
Questo articolo è tratto da
Ombre e Luci n.163