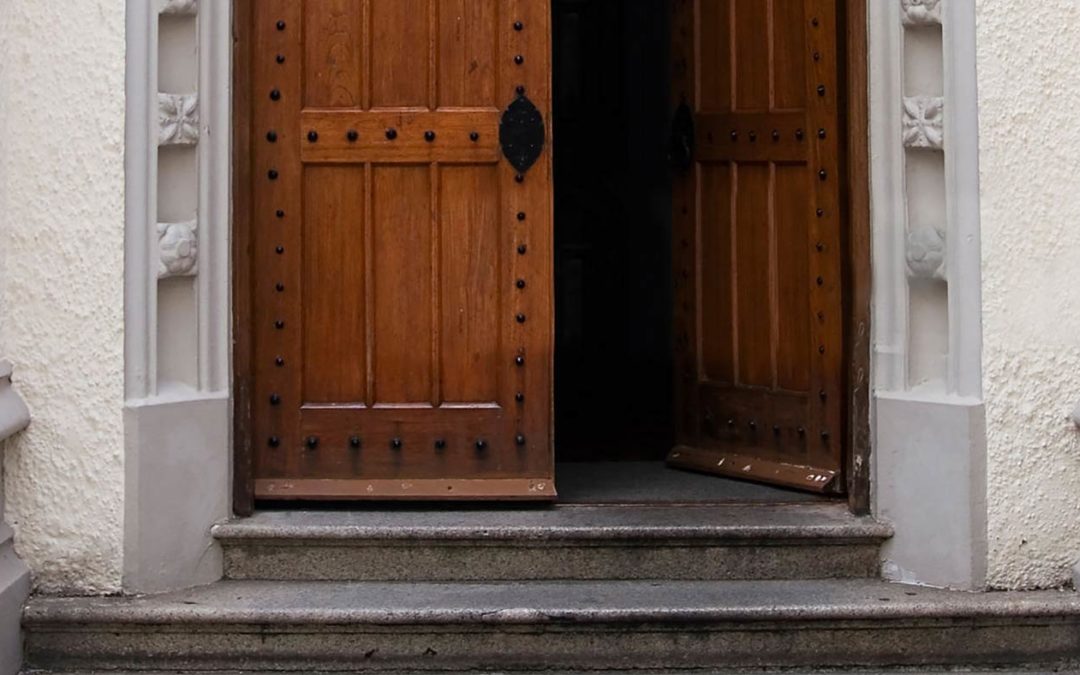«Quando i miei figli erano piccoli io e mia moglie ci ostinavamo a portarli a messa tutti e cinque insieme a noi. (…) Era un modo per testimoniare, per dire che fare figli, avere una bella famiglia fa parte dell’essere cristiani e arricchisce la comunità. E per dire che la comunità avrebbe dovuto rallegrarsi nel vedere tanti bambini in giro. I miei figli lo sapevano e facevano casino. Un giorno però al parroco girarono i maroni e dal pulpito sbottò, fissandomi: “Adesso porti fuori la bambina!”. Io non mossi un passo, un sordo che non vuol sentire, lo sguardo puntato dritto negli occhi del povero parroco che non riusciva a finire la predica per colpa di un bambino». Così scrive Alberto Porro in apertura di Come sopravvivere alla Chiesa cattolica e non perdere la fede (Bompiani 2019), breve e denso manuale di un credente ancora innamorato ma parecchio infastidito da un’istituzione sempre più incapace di dialogo e confronto con i suoi membri.
Sebbene l’autore non ne faccia mai cenno, le sue considerazioni sono perfettamente mutuabili al rapporto tra Chiesa cattolica e disabilità. Perché dopo anni di esperienza sul campo, possiamo affermarlo con convinzione: la Chiesa ha un serio problema con le persone che presentano qualche disabilità. Rarissimamente infatti, nonostante i proclami, è stata ed è capace di accoglierle.
E dire che le premesse sono le migliori. Da millenni infatti la Chiesa dice di voler essere accanto agli ultimi – anche se, a onor del vero, la coraggiosa parola “scarti” è diventata comune solo grazie a papa Francesco. La Chiesa ad esempio, con un impegno non ravvisabile in altre istituzioni, condanna con forza anche l’aborto terapeutico, quell’aborto cioè che impedisce la nascita di un bimbo con disabilità.
Eppure, da quando la persona con disabilità fa la sua comparsa nel mondo, la Chiesa non fa nulla per aiutarla, o per aiutare la sua famiglia. Gli esempi potrebbero essere infiniti. Gli asili e le scuole gestiti da religiose e religiosi molto difficilmente li accolgono, mentre troppo spesso i parroci fingono di non vederli e l’accesso ai sacramenti è una corsa a ostacoli. Quante sono state inoltre le messe dalle quali ci hanno invitato a uscire perché la disabilità dava fastidio, era rumorosa, perché pretendeva di pregare con i gesti ritmati dell’autismo, con le canzoni fuori tempo di chi invoca Dio stonando un po’, con le gambe incrociate seduti in terra, in adorazione troppo vicini all’altare? Quante, ancora, sono state le messe a cui ci hanno suggerito di non partecipare (“Non a quella di mezzogiorno, c’è tutta la parrocchia, i bambini normali potrebbero impressionarsi”)? Quanti i pellegrinaggi parrocchiali durante i quali siamo stati lasciati indietro? Non è certo un caso che dal rifiuto a partecipare opposto a una coppia con due figli con disabilità sia nato il movimento internazionale Fede e Luce.
Del resto, della difficoltà di accettazione è spia innanzitutto il linguaggio: si contano veramente sulla punta delle dita i sacerdoti che non utilizzino – assieme a quintali di frasi stucchevoli – il termine “malati” riferendosi alle persone con disabilità. La malattia è un’alterazione dello stato di salute; la disabilità no.
Per non parlare infine di quanto tante comunità italiane di Fede e Luce fatichino a trovare un sacerdote che le accompagni nel loro cammino. I pochi che arrivano, passano come meteore: il mondo della disabilità è un mondo che non conoscono, e che per questo li spaventa. Non sanno che pesci pigliare: paternalismo, carità pelosa, fastidio, imbarazzo, incapacità di ascolto… Possibile che nella vita quotidiana o in seminario i sacerdoti non abbiano mai incontrato o sentito il bisogno di incontrare una persona con disabilità? Possibile che a nessuno dei loro professori, padri spirituali o che so io non sia mai venuto in mente che esistono anche questi “scarti”?
Evidentemente no se in Le grandi domande della vita (Morcelliana 2018) Jean Vanier scriveva «raramente ho sentito dire alle autorità ecclesiastiche: “Andate negli istituti, nelle case di riposo, nei pensionati, ai margini della società, e diventate loro amici. Portateli nelle vostre comunità, fate scoprire loro quanto sono preziosi!”. È una questione di giustizia, di libertà per la nostra famiglia umana! Eppure spesso la Chiesa non sembra interessarsene. Magari ci si congratula con L’Arche o con alcune persone che si sono dimostrate particolarmente buone (…). Ma non è questione di essere buoni, è questione di fare quello che è giusto».
Ed è decisamente ingiusto che migliaia di persone con disabilità fisica o psichica non si sentano accolte nella casa del Signore. Non dico capite, ma almeno accolte.
In La notte ha la mia voce (Einaudi 2017) la scrittrice atea Alessandra Sarchi si domanda: «Non era stata stabilita, alla fine dell’antichità, all’inizio della nostra era, una nuova legge che diceva che gli ultimi dovevano essere protetti, amati, sostenuti?». Fa male dirlo, ma è evidente che questa nuova legge fa ancora fatica a trovare spazio nella quotidianità delle nostre parrocchie. In evidente violazione del messaggio evangelico.
Questo articolo è tratto da
Ombre e Luci n. 147, 2019

SOMMARIO
Editoriale
Chi cura le anime? di Cristina Tersigni
Focus: Spiritualità e disabilità
La Chiesa ci accoglie davvero? di Giulia Galeotti
Uno dei tanti di Roberto Brandinelli
Ma stai pensando a me? di Sergio Sciascia
Una dedica che andrebbe cambiata di Gianni Marmorini
Per una teologia meno disabilitante di Luca Badetti
Intervista
Lucrezia e il Marco di ieri e di oggi di Giulia Galeotti
Testimonianze
L'alfabeto che manca di Serena Sillitto
Dall'archivio
Cosa dirvi di più? di Stéphane Desmandez
Associazioni
Catalogo di prelibatezze di Enrica Riera
Fede e Luce
A metà tra un conclave e una seduta di autocoscienza di Serena Sillitto
Spettacoli
Il cantiere delle buone notizie di Alessandra Moraca
Rubriche
Dialogo Aperto n. 147
Vita Fede e Luce n. 147
Libri
La tua vita e la mia di Majgull Axelsson
Questa è bella! La storia di Rospella di Anna Sarfatti
Per tutti persone di Azione Cattolica Ragazzi
Amore caro di Clara Sereni
Diari
Sempre di Benedetta Mattei
Ogni tanto dobbiamo svagarci di Giovanni Grossi